Se fare la Digital Strategist significasse soltanto sviluppare nuove strategie di marketing, non lo troverei così divertente. Per il 90% del tempo, lavorare su una strategia significa:
ascoltare e coinvolgere il più possibile un team di lavoro,
cercare soluzioni a problemi complessi,
trovare un modo per adattarsi (se non puoi anticiparli) ai cambiamenti del mercato.
C’è un metodo, che è anche una teoria, ma che forse è più una tecnica da cui traggo spesso spunto per lavorare su questi 3 aspetti (coinvolgimento, soluzioni, cambiamento): la Sinettica di Gordon.
Prende il nome dal termine greco synektiké (unione, coesione) e da qui nasce il titolo del libro “Synectics”, con cui William Gordon la propose nel 1961. Il pensiero sinettico, dice, è il processo che porta a collegare elementi apparentemente non connessi.
L’obiettivo di una seduta sinettica è risolvere un problema in modo creativo partendo da ragionamenti più ampi e meno definiti rispetto alla vera questione da risolvere.
Continua a leggere e vedrai che tra qualche minuto questa frase ti suonerà più chiara.
La teoria
L’atteggiamento mentale da mantenere durante una seduta di sinettica è di confidare in ciò che suona strano, allontanando le cose di cui generalmente ti fidi. Sempre secondo Gordon, questo atteggiamento aiuta a liberare il nostro pensiero irrazionale, sblocca il processo creativo e lascia fluire l’inconscio.
La sinettica si applica molto bene ad oggetti tecnici (es.: come migliorare un tostapane), ma può essere utilizzata anche in altri ambiti (es. come possiamo migliorare la nostra strategia di marketing).
La sinettica di Gordon si fonda su 3 principi:
ogni persona può diventare più creativa se comprende i processi psicologici alla base della creatività.
in un processo creativo, la componente emotiva è più importante di quella intellettuale, l’irrazionale più del razionale.
comprendere ed esercitarsi su emozioni e accostamenti irrazionali è alla base del successo di ogni ricerca creativa
Il gruppo di lavoro
Le sedute di sinettica si effettuano in gruppo e la dimensione idealmente non deve superare le 6-7 persone, preferibilmente disposte in semicerchio e rivolte verso la persona che farà da facilitatore.
Gestire una seduta di sinettica non è semplice: da un lato serve esperienza per rendere le persone pronte ad accettare il gioco metaforico, dall’altro occorre capire quando far cambiare strada o quando rafforzare un’idea e - più in generale - aiutare nel processo decisionale.
La seduta
Si svolge in 4 macro fasi:
definizione, elaborazione e analisi del problema. Il gruppo identifica chiaramente quale questione o ostacolo occorre risolvere. Il facilitatore le seleziona e organizza le informazioni emerse in questa fase in modo da renderle chiare e visibili a tutti. Eventuali soluzioni che emergono in questa prima fase sono solitamente poco innovative; prima di procede è opportuno filtrare tale soluzioni escludendo tutto ciò che non è il linea con l’obiettivo finale.
es. “vogliamo vendere più tostapane”, “i nostri macchinari sono vecchi”, “il nostro design è fuori moda”, “servono interruttori più grandi”…
distacco Porre maggiore distanza dal problema reale consente maggior libertà di pensiero ed evita l’attaccamento a ciò che già si sa riguardo al problema.
In questa fase, quindi, l’obiettivo specifico viene accantonato e al suo posto viene chiesto al gruppo di discutere una questione centrale rispetto all'obiettivo generale. Ad esempio, nel caso in cui l’obiettivo fosse quello di migliorare un tostapane, il facilitatore può chiedere al gruppo cosa significhi per ciascuno "cuocere" e “colazione”. Questa fase di brainstorming aiuta a svuotare la mente e a buttare fuori tutto quello che esce in modo spontaneo.es. “scaldare”, “mattino”, “sfamare”, “sonno”…
escursione (tramite le analogie) Il gruppo viene poi stimolato a fornire reazioni immaginative su alcuni elementi che caratterizzano gli obiettivi scelti. Questi passaggi dovrebbero "rendere familiare lo strano", come dice Gordon.
Le analogie utilizzabili sono di 4 tipi:
Analogia diretta Il gruppo inizia a fare comparazioni con oggetti, tecnologie o situazioni/contesti simili. Per es. “come risolveremmo il nostro problema se, invece di tostapane, vendessimo aspirapolveri?”, “che soluzioni tecnologiche esistono nel settore dei videogiochi?”, “come sarebbe il nostro prodotto se fosse solo per bambini?” …” Questo permette di ampliare l’orizzonte di osservazione e trovare nuove connessioni perché si parte da situazioni simili, ci si sposta verso concetti più astratti e si collegano elementi lontani dal problema e dal suo contesto tradizionale. L’analogia diretta di solito funziona bene perché da risultati chiari e immediati.Analogia personale Ogni partecipante si identifica emotivamente con un oggetto a scelta o con una situazione tipici per il problema in questione, consentendo un’esplorazione più emotiva del problema. Il rischio di questa analogia è che diventi poco più di un gioco di ruolo: se si decide di percorrerla occorre gestirla con molta attenzione. es. “se io fossi l’interruttore?”, “se io fossi il pane da toast?”, “se io fossi il mobile della cucina”…
Analogia simbolica Questo tipo di analogia esplora il mondo dei miti, delle favole, dei simboli e delle immagini per descrivere il problema. Il simbolo scelto può essere tecnicamente impreciso, ma esteticamente soddisfacente. Per esempio il tostapane può diventare una bacchetta magica e trasforma semplici ingredienti in una pietanza, o parte dell’avventura di una fetta di pane che passa dal frigo alla bocca… Consiglio mio: utilizzare in fase avanzata del percorso, quando le persone hanno già iniziato a ragionare in modo sciolto, per evitare di perdersi troppo per strada o di bloccare il gruppo.
Analogia fantastica Per formulare analogie fantastiche si prova a immaginare un mondo che non esiste, dove le regole non esistono: “se il tostapane sapesse cantare?”, “se il tostapane potesse muoversi?”, “se le dimensioni di un toast fossero di 10 volte superiori”, “se un toast pesasse kilogrammi?”…
In gruppi molto attivi può risultare interessante iniziare proprio dalle analogie fantastiche, per liberare fin da subito la mente da ogni vincolo. Se invece vuoi agire con più prudenza, puoi lasciare questo esercizio come ultimo.Riflessione, osservazione, verifica Si ragiona sui risultati emersi e sui percorsi di soluzione proposti. Si valutano i contributi generali che il facilitatore schematizza in un nuovo punto di vista. es. “il tostapane fotovoltaico è fattibile, i prossimi step sono”…
La parte più complessa del processo ideato da Gordon è certamente quella che riguarda le analogie: il gruppo di lavoro deve sentirsi guidato, sostenuto, non giudicato e libero. Non è necessario esplorare tutte le analogie e non è nemmeno necessario farlo in un ordine preciso, è però fondamentale che il facilitatore, ogni tanto, effettui delle scelte: l’aspetto più importante (e difficile) è intercettare la strada più interessante e spostare l’attenzione del gruppo in quella direzione.
I Pro
il problema posto viene completamente compreso prima di produrre la soluzione finale
il processo nel complesso risulta più efficace rispetto al brainstorming, che tende a convergere troppo rapidamente
si utilizzano entrambi gli emisferi del cervello: destro (più sognatore) e sinistro (più analitico) rendendo il pensiero più libero
si arriva più facilmente a formulare pensieri nuovi, idee, invenzioni
I contro
il processo potrebbe richiedere molto tempo prima di essere concluso (ma puoi anche effettuare più sessioni frammentate)
ad ogni membro del gruppo è richiesto di essere molto concentrato durante tutto il processo
se il gruppo è riluttante a fantasticare, non produce buoni risultati
funziona meglio per risolvere problemi individuali che su problemi di gruppo / sociali
la figura del facilitatore è centrale e incide sul risultato: occorre un grande sforzo per gestire il gruppo, per mantenere il flusso della discussione e guidare verso l’obiettivo.
Opportuno disclaimer
Ci sono due metodi per risolvere un problema: in modo razionale ed in modo creativo.
La soluzione razionale di solito arriva interrogando dati, conoscenze pregresse e informazioni esistenti. La soluzione creativa, invece, si genera tramite percezioni, memoria ed elaborazione e la sinettica sfrutta questa capacità mentale di collegare elementi apparentemente irrilevanti, smontando le cose per ricomporle con nuove intuizioni.
Esistono casi in cui servono entrambi gli approcci e casi in cui ne serve soltanto uno. Nessuno strumento va bene sempre e parte del lavoro di strategist sta anche nello scegliere il framework migliore a seconda del problema e del contesto. Quando cerco una soluzione creativa applico spesso la Sinettica di Gordon (tutta o in parte); per tutto il resto del progetto, mi affido ai numeri.




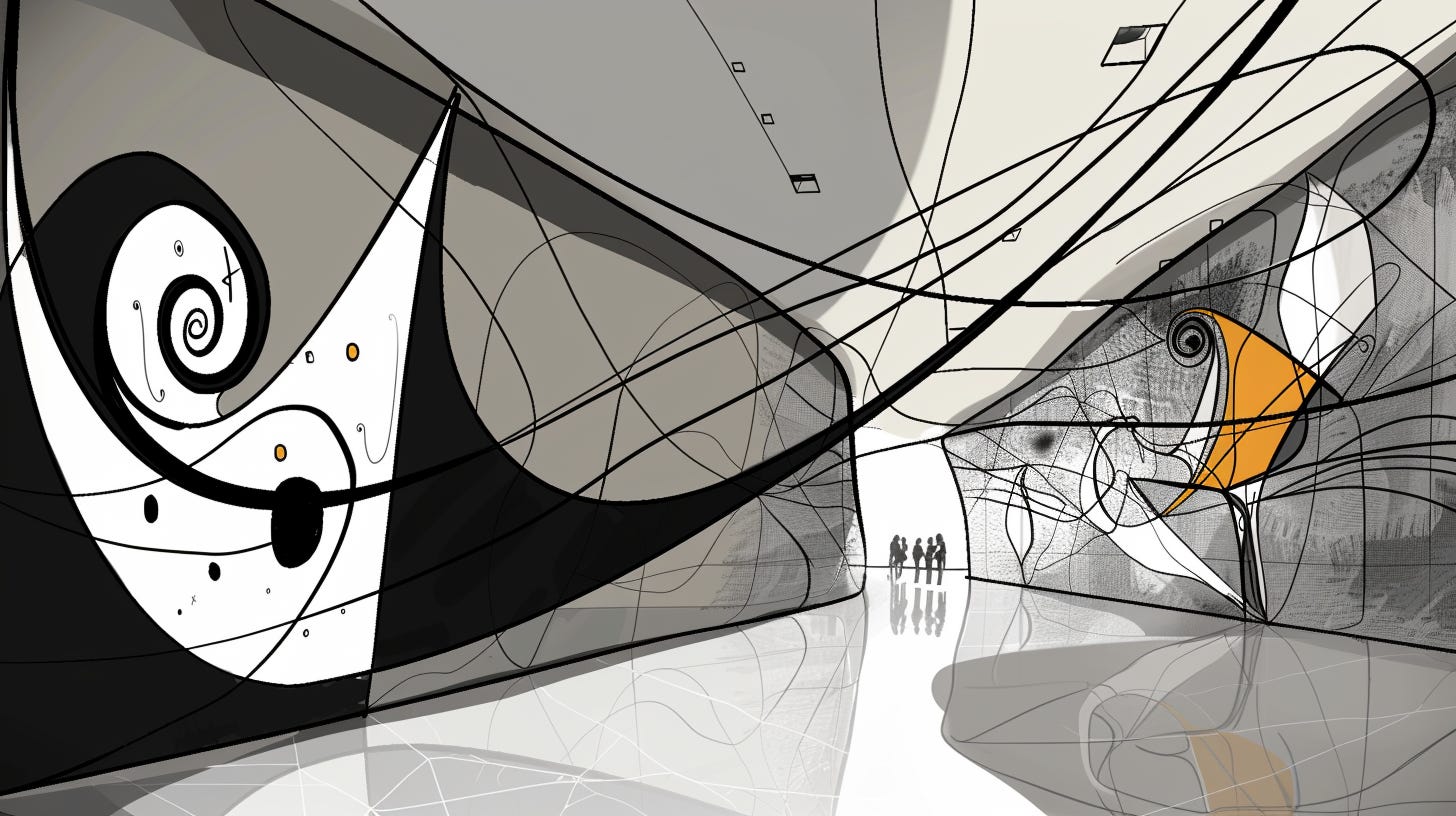
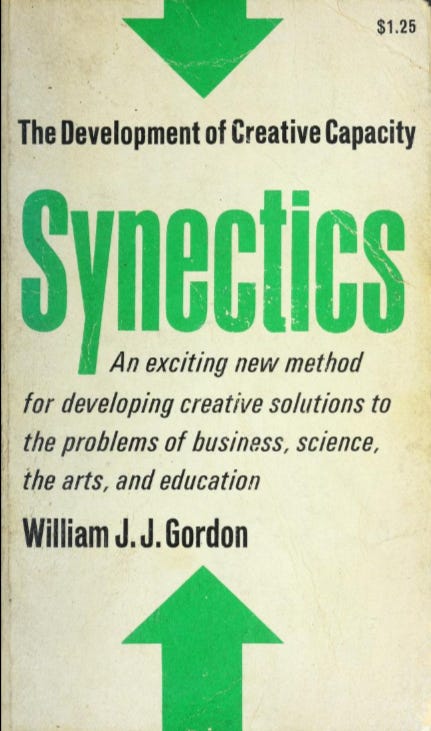

@Alessia, ti ringrazio moltissimo per questo articolo.
Sono sempre alla ricerca di nuovi punti di vista e teorie illuminanti.
Ti faccio i complimenti perché, in un panorama di "ricicciatori" seriali delle solite minestre riscaldate spacciate come rivelazioni, tu hai parlato, e in dettaglio, di qualcosa di originale.
Trovo l'approccio sinettico molto interessante, anche se, a mio parere, prima di parlare di metodi per essere creativi (ecco il pianto...) bisognerebbe parlare di metodi per non essere conformisti.